Tutti i videogiochi della mia vita (II puntata)
Joust #9
Non ho mai capito perché sotto alla casa di mia nonna ci fosse questo bar dove non ho mai visto anima viva, ma soprattutto non ho mai capito perché dentro ci fosse un cabinato con dentro Joust a cui – a memoria d’uomo – giocavo solo io nei pomeriggi nel quali fuggivo dalla casa di mia nonna gravido di monetine da duecento lire.
Joust è un gioco in cui tu sei un cavaliere medievale che cavalca uno struzzo volante e deve combattere contro altri cavalieri di uccelli al di sopra di un lago di lava incandescente e deve fare anche presto perché se non sconfigge subito i suoi nemici arriva un pterodattilo incazzatissimo. Se colpisci un cavaliere questo si trasforma in un uovo da cui, se non ti sbrighi a prenderlo, nasce un altro cavaliere medievale. Dalla lava – è bene dirlo – spuntano fiamme che di tanto in tanto mutano in mani antropomorfe che trattengono gli uccelli in volo.
Letto così può sembrare assurdo, eppure un mondo del genere era possibile. Joust era ipnotico. L’assurdità dell’ambiente veniva messa in secondo piano dal fatto che il tutto funzionava perfettamente. Era una perenne sfida e gli elementi estranei, il guerriero medievale, lo struzzo, i colori giallo e azzurro associati al bene, il pterodattilo, rendevano questo possibile mondo inesplicabile. Cosa sarebbe potuto succedere ancora? Se diamo per buona l’accostabilità di questi elementi simbolici, cosa ancora sarebbe arrivato negli scuri livelli che ci attendevano?
Io ero lì, ai piedi del biscione di cemento armato di Marassi, nell’oscurità di questo bar abbandonato che infilavo le mie duecento lire e sognavo.
Ali Baba and the Forty Thieves #10
Ali Baba and the Forty Thieves è uno di quei giochi che ancora adesso mi metterei lì e rifarei da zero. Tempi di gioco lunghissimi, icone simboliche e funzionali, mistero e tantissimi luoghi da esplorare, le stanze che vedi solo quando fisicamente ci entri dentro, suoni 8-bit che spezzavano il silenzio della partita che – spesso – giocavo con fratello, cugini, amici, chiunque, perché Ali Baba and the Forty Thieves era multiplayer, a turni, ma multiplayer.
E il tema di Sheherazade di Rimskij-Korsakov che ritornava tragico e epico nello stesso tempo ogni volta che il nostro personaggio si metteva a leggere le rune trovate nel mondo di Ali Baba (sperando che non esplodessero dopo essere state lette): questo gioco, opera di Stuart Smith nel 1980, era una vera e propria gemma nel panorama dei videogame di quell’anno.
Il programmatore avrebbe poi programmato quel lavoro incredibile per l’epoca di Adventure Construction Set e poi sarebbe sparito letteralmente nel nulla. Anni fa mi ero messo a cercare notizie su di lui ed avevo scoperto di non essere il solo ad averlo fatto. Ma Stuart si era ritirato, si era messo a fare tutt’altro.
L’unica cosa che ero riuscito a trovare anni e anni fa era una sua foto dell’epoca: lui con la moglie, tre figli/e biondi, tutti che sorridono alla macchina fotografica da un tempo che non esiste più.
Thief/a #11
Allora la storia di Thief/a, programmato dal mitico Bob Flanagan, è che – non voglio mentirvi – non credo che ci sia nessuna storia. Bob Flanagan non sapevo nemmeno chi fosse prima di pochi minuti fa. È un programmatore di videogiochi, lo è ancora adesso.
Thief/a è in realtà un anonimo clone di un ancora più sconosciuto videogame degli anni ottanta. Sei in un labirinto, devi sparare a dei robot, se ci metti troppo appare una faccia felice che ti uccide. Fine.
Eppure io ho giocato a ore e ore a Thief/a, me lo ricordo, come a centinaia e centinaia di altri videogame anonimi che sono qua a conteggiare come i nodi del rosario. Perché giocavo a Thief/a?
Perché – credo – prendevo le misure. Prendevo le misure con quello che il digitale e i videogame potevano fare. Giocavo ore a Thief/a perché mi piaceva muovere un joystick e vedere il mio omino correre, sparare, uscire da qualche parte.
Per vedere se prima o poi sarebbe successo qualcosa di diverso.
Per continuare ad aggiungere i piccoli sassolini che hanno poi creato la spiaggia della mia estetica videoludica.
Non sono qui a consigliarvelo, a dirvi, oh questo è un grande classico, provate a giocarci, niente di tutto questo. È proprio l’odore dell’umidità che fanno i ricordi dentro, gli elementi base che apparivano in quei primi anni ottanta per la prima volta.
Lazer Maze #12
Ho sempre odiato i giochi “scacciapensieri”, quelli senza trama, basati solo su elementi di logica o di rapidità. Tipo Tetris, mai amato, pochissime partite.
Sempre odiati tutti tranne Lazer Maze.
In Lazer Maze sei una specie di astronauta con un fucile laser in un punto preciso di un labirinto di specchi. Devi capire dove finirà il tuo colpo e scriverlo: nel punto da te scelto andrà un antagonista con una bomba. Se hai calcolato giusto l’antagonista morirà altrimenti ti lancerà contro la bomba.
Lazer Maze, non so perché, mi dava un grande appagamento, man mano che si avanzava nei livelli e aumentavano gli specchi e il percorso da calcolare diventava sempre più complesso. Provavo proprio un piacere “intellettuale” nel vedere il raggio che rimbalzava negli specchi riproducendo il percorso che avevo già disegnato nella mia testa.
Probabilmente con le mie partite con Lazer Maze stavo preparando nel mio cervello lo spazio necessario per capire le regEx.
Pitfall II #13
Pitfall II è stato un grande amore: un porting di uno dei più grossi giochi di David Crane e in più un porting più che decente (anche se avrei giurato che la versione Apple II non avesse la colonna sonora, che invece c’è: ah – memoria).
Pitfall presentava una situazione di partenza che era una sfida: il protagonista doveva raggiungere una specie di topo (che nella storia è in realtà un puma) che era letteralmente sotto di lui. Ma per raggiungere quel punto Pitfall avrebbe dovuto esplorare e districarsi in un enorme cava sotterranea, dove avrebbe trovato tesori, mostri, palloncini volanti e – incidentalmente – anche sua nipote.
Il gioco passava di schema in orizzontale e scrollava in verticale, dando l’idea di un mondo enorme, per i videogame dell’epoca, e parte della bellezza del gioco era proprio in questa continua esplorazione e raggiungimento di passaggi, stanze segrete, percorsi.
Pitfall 2 è uno di quei giochi che ho finito, in quanto non presenta il solito “fottuto labirinto della morte” alla pacman, che si ripete per sempre ma ha una sua storia, per quanto semplice, e un punto finale che conclude il videogame.
Ricordo anche la sera in cui l’ho finito, dopo ore e ore di gioco, con il joystick a potenziometri che ogni tanto scattava tragicamente nell’ultimo lunghissimo percorso di risalita protetto da feroci uccelli.
Sono arrivato a quel dannato puma che da mesi cercavo e mi aspettavo che nella sala di casa mia entrasse David Crane con ragazze dai capelli colorati, bandierine americane, coriandoli e una grossa scritta che recitasse “GLORIA IN EXCELSIS VIDEOGAME” o qualcosa del genere: invece, nell’oscurità della stanza, Pitfall si è messo a saltare. Di gioia immagino.
Sono rimasto così a fissare Pitfall che saltava per un po’, mi sono girato per vedere se *davvero* non arrivassero le ragazze con la scritta “GLORIA IN EXCELSIS VIDEOGAME” e – niente – ho spento con l’appagamento comunque nel cuore.
Popeye #14
Olivia che ci ama e ci lancia cuori che dobbiamo raccogliere prima che cadano in acqua e vadano dispersi, Bruto che corre, salta e cerca di darci ceffoni da un livello all’altro, la strega del mare che ci lancia contro teschi e bottiglie, Poldo che mangia e ci fa da contrappeso per una specie di catapulta umana, Pisellino appeso a un palloncino a cui possiamo aggrapparci, insomma, Popeye, il videogioco da bar, un gioco che rubacchiava da qua e là: dentro c’era un po’ di Donkey Kong (e Bruto è lo scimmione per antonomasia) ma anche un po’ di Pac-Man (gli spinaci sono la pallina grossa che rende forti, per un po’).
Popeye era uno di quei giochi che mi mettevano ansia, ma per cui provavo una strana attrazione. Era un gioco difficile, sfidante, ma era anche un gioco che mi metteva tristezza. Bruto mi metteva tristezza, la sua rabbia per non essere amato, il suo collerico modo di affrontare il mondo.
Bruto non era mai felice, non lo sarebbe mai stato, anche dopo migliaia di ‘game over’, anche dopo essere uscito per l’ennesima volta dall’acqua per un cazzotto di Popeye.
Io ero Braccio di Ferro, ma soffrivo per Bruto. E avevo paura della sua cieca rabbia.
Out Of This World #15
Anche con il primo Macintosh tendevo a copiare tutto quello che mi capitava sotto mano, una sorta di backup preventivo/compulsivo, e a un certo punto copio questo gioco che si chiama Out Of This World (conosciuto anche come Another World) e per un bel po’ di tempo non ci gioco perché si apre con una scena introduttiva che schianta il mio povero Macintosh LC, tutto va a scatti e quindi io lo chiudo e lo tengo lì, a futura memoria.
Finché un giorno non decido, vabbè, di provare e vedere se si riusciva ad andare avanti, vedere cosa succede e in pratica scopro che superata la scena introduttiva il gioco poi funziona abbastanza bene.
E il gioco è una bomba. Out Of This World non è solo uno dei videogiochi della mia vita, è uno dei videogiochi importanti della mia vita, quelli che ci rimani attaccato come rimani attaccato a un romanzo che ti ha preso, o a un amo nascosto sotto a dei vermi, se sei tipo una cernia.
Out Of This World inizia che sembra un arcade, ma non è il solito arcade che il personaggio viene piazzato nel mezzo del mondo e, ciaone, gioca.
Out Of This World è un arcade, ma puzza di avventura, puzza di film, puzza di racconto e puzza di esplorazione. Out Of This World rompe un sacco di normali dinamiche di gioco arcade, le sfrutta, ma poi le rompe: cambi di prospettiva, primi piani cinematografici, scene di raccordo, ironia, ecco: ironia, umorismo, sarcasmo, parodia, inseriti all’interno di un arcade funzionale e avvincente.
E soprattutto c’è un mondo, un altro mondo.
Non ci sono imbarazzanti spiegoni, ma siamo dentro un mondo alieno e ci spostiamo dentro scoprendo cose *coerenti* narrativamente fra di loro.
Per me fu un colpo di fulmine arrivato nel momento giusto perché, su Macintosh, era davvero tanto tempo che non giocavo a qualcosa che valesse la pena e Out Of This World era uno step oltre gli altri arcade a cui avevo giocato fino a quel momento.
Ancora oggi a decenni di distanza Out Of This World impatta il mondo dei videogiochi, ci sono citazioni di questo gioco anche in arcade indie usciti recentemente (The Eternal Castle per dirne uno), e – nel ricordo lontanissimo che ho di quel gioco – mi rimane qualcosa, l’idea di fare una storia, di raccontare, di disegnare mondi che non esistono, di andare oltre quello che si era fatto fin a quel momento.
Twerps #16
Non credo che riuscirò mai a terminare questa lista dei videogiochi a cui ho giocato nella mia vita perché sono oggettivamente troppi, di molti avevo anche rimosso la memoria finché non mi sono capitati per caso sotto gli occhi.
Tipo Twerps. Twerps è un gioco sconosciuto, spero, faceva parte di quelle centinaia di giochi che mi arrivavano in anonimi floppy disk da 5 1/4, i cosiddetti “dischi gioco” perché erano pieni all’orlo di giochi crakkati.
Quando qualche giorno fa ho visto su youtube un video con un frammento di Twerps ho detto ma cavolo, Twerps. Quanto ci ho giocato. Era uno dei tanti, nella massa.
Perché ci giocavo: dovete immaginarvi che questi giochi mi arrivavano via pacchetti postali da altri appassionati. Della maggior parte non conoscevo nulla, nessuna informazione, internet era lontanissimo dal venire. Era già gioco capire cosa fosse quello che infilavo nel mio floppy.
Twerps è un gioco piccolo, ma con alcune ambizioni: parte con una scena che fa da introduzione: da una base spaziale parte una nave, la vediamo poi esplodere sopra un pianeta pieno di crateri simillunari e vediamo dei piccoli alieni salvarsi dall’esplosione e nascondersi nei crateri. Forse. Fine dell’introduzione.
A questo punto parte la nostra navicella e si trova davanti a decine di alieni chiaramente ostili a protezione di un pianeta. Bisogna sparare e ammazzarli tutti. Perché? Non lo so. Non ancora.
Giocavo proprio per vedere cosa sarebbe successo dopo. Per capire la storia, se ce ne era una. E in effetti c’era: uccisi tutti gli alieni non appaiono altri alieni più cattivi, ma ci ritroviamo nell’atmosfera del pianeta, quello con i crateri che abbiamo visto nell’introduzione.
E qui scatta una sorta di altro gioco, l’astronave deve atterrare, c’è la gravità, è una specie del classico minigioco in cui bisogna far atterrare l’astronave, ma integrato all’interno di una storia. E una volta atterrato, ecco che dall’astronave parte una navetta che atterra nei pressi dei crateri lunari.
E qui inizia un terzo gioco ancora: dalla navetta scendiamo noi, finalmente, e non siamo esseri umani. Siamo piccoli alieni simili a quello dello space invader. Il nostro scopo è andare nei crateri lunari e salvare i nostri fratelli che erano precipitati sul suolo dopo l’esplosione della loro nave. Piccoli minigiochi incastrati assieme per ottenere una storia, una narrazione omogenea. Non è poco negli anni ottanta.
Una volta salvati gli alienini torniamo alla nave che riparte e deve di nuovo sconfiggere decine di alieni cattivi prima di tornare alla base.
La bellezza era lì, nel giocare un gioco e giocando svolgere una storia, scoprire le motivazioni della grafica, del gameplay, dei suoni, del vuoto spaziale.
Poi, a ripensarci oggi, il fatto di dover trucidare sistematicamente una ottantina di alieni per salvarne setto o otto della nostra razza, è molto americano.
Escape From Rungistan #17
Era circa il 1985 e io stavo giocando a una delle più belle avventure testuali/grafiche mai scritte, Escape From Rungistan. Era natale.
In Escape From Rungistan tu sei un turista messo in carcere nel Rungistan, non meglio precisato stato Molto Lontano Dall’America (da qui in poi MLDA). E devi fuggire. L’umorismo americano verso l’arretratezza del Rungistan forse oggi ricadrebbe in piena cancel culture.
Il gioco è effettivamente ironico, spartana ma funzionale la grafica vettoriale e ogni tanto lo schermo statico si anima e tu devi scrivere quindi i comandi tipici delle avventure testuali entro la fine della azione.
Tipo, passa un topo, devi scrivere GET MOUSE prima che il topo rientri nel suo buco, una interessante convergenza tra arcade e interactive fiction.
Molte di quelle schermate vettoriali ormai sono incise nel mio cuore.
Anyway, stavo giocando, era natale e stavo scalando una montagna dopo essere fuggito dalla cella del Rungistan, cercavo di raggiungere il confine. Salgo, salgo, finché non mi trovo in una bella vallata innevata: si sente una musica natalizia e inizia a scendere la neve, nello schermo. Effetto neve. Sorrido e mi godo la simulazione, inarco la schiena e metto le mani dietro al collo, chiamo mio fratello per fargli vedere la cosa. La neve continua a cadere.
Arriva mio fratello e in quel momento appare una scritta e il gioco finisce. La scritta dice, “sei rimasto troppo tempo sotto la neve, sei morto assiderato”. E io resto lì a leggere la scritta e penso, tanto amore, davvero tanto amore.
MDK #18
Non so chi avesse scelto di mettere MDK in bundle con l’iMac, ma chiunque sia ha la mia benedizione. Giocato completamente alla cieca, solo perché era assieme all’iMac, MDK era un gioco dirompente, un arcade in 3D che da subito prendeva in giro se stesso.
Gli oggetti che il protagonista trovava, “La bomba atomica più piccola al mondo”, il “dummy decoy”, una sorta di sosia gonfiabile di noi stessi, i caricaturali boss finali, i nemici che — nella parte introduttiva in cui dovevamo capire come sparargli — giravano con un bersaglio in mano in modo da aiutarci a colpirli al meglio, la finta stanza campestre in cui a un certo punto il protagonista finisce e che si rivela fatta di quattro pareti “piatte”, grandissima ironia su tutto l’impianto dei giochi 3D: il gioco era pieno di ammiccamenti e ironie.
Ma non era una farsa: il gameplay era serrato, con una colonna sonora perfetta e diversi livelli dannatamente difficili. Oggi forse mi terrebbe lontano l’eccesso di seek and destroy, ma all’epoca ci passai sopra per la cura di tutto il resto.
Zaxxon #19
C’era questa cosa che io avevo un Apple 2 che – inizio anni ottanta – era piuttosto atipico, tutti i miei amici avevano un Commodore o uno Spectrum e quindi la maggior parte dei videogiochi a cui giocavo erano sconosciuti in Italia, e questo – da un lato – mi metteva a contatto con videogame unici, dall’altro provavo come un senso di esclusione da un consesso di videogiocatori che parlavano e scrivevano su riviste di videogame che io – se andava bene – potevo vedere solo in cabinato.
Quindi quando mettevo le mani su un porting per Apple 2 di un gioco mainstream provavo una specie di assimilazione, mi sentivo di far parte di un processo di videogaming più grosso di me, era qualcosa che – evidentemente – mi serviva come senso di appartenenza.
Zaxxon è uno di questi titoli: visto per anni fotografato nelle riviste di videogame & computer, finalmente ero riuscito ad averlo con i soliti scambi di liste di software crakkato. Zaxxon era il tipo gioco di astronave/aereo che va mentre tutto gli scrolla sotto e spara e ammazza più cose possibile senza essere ucciso. Raid in pratica.
Solo che Zaxxon era in 3D parametrico (non so perché ho scritto parametrico, non so nemmeno esattamente cosa significhi parametrico, ma ho sempre associato Zaxxon al 3D parametrico, evidentemente è qualcosa che ho letto negli anni ottanta e che si è fermato lì) e ha una grafica semplice ma efficace, verosimile nel creare questi piccoli ambienti da distruggere.
Il porting per Apple 2 era tutto sommato un porting dignitoso. Ci giocavo per il gusto di giocare a Zaxxon, le partite erano un modo per esserci anche io, per poter finire le mie partite e andare a giocare a pallamuro con i ragazzi sottocasa portando dentro di me quel modo di vedere dall’esterno le cose, me stesso, le mie esplosioni sottostanti.
Cave Story #20
Cave Story è il videogioco a causa del quale ho smesso di giocare ai videogiochi per dieci lunghi anni. Era il 2007 e avevo scoperto questo platform incredibile, con una storia, un gameplay complesso e strutturato, una colonna sonora 8-bit perfetta, personaggi non banali e mi ci ero buttato giocandoci per diverse settimane, tanto che me lo ero portato dietro durante il viaggio di nozze con mia moglie.
In pratica, proprio in quell’occasione, stavo cercando di finire un livello in cui ero sopra una specie di carroarmato e cercavo di farlo a pezzi, qualcosa del genere, e ogni volta morivo, e ci riprovavo e morivo e ancora ci riprovavo e – insomma – ad un certo punto mi sono reso conto che stavo lavorando sulle mie skill umane per ore, letteralmente per ore, solo per il fine di fare saltare in aria un carro armato immaginario.
È davvero questo, mi sono chiesto, quello che voglio da un videogioco?
È stato un po’ come Obelix che esce dal calderone e si rende conto che non ne può più di pozione magica, non di quel tipo almeno. Era il secondo segnale, il primo era arrivato con l’abbandono di un altro grande gioco di cui parlerò in un altro momento, Giants: Citizen Kabuto.
L’abbandono di Cave Story è stato un passaggio, il terminare l’interesse per un certo tipo di videogame e iniziare a coltivare l’attesa per un altro tipo di videogame, attesa che terminerà nel 2017 con la scoperta di A Night In The Woods e della novelle vague degli indie narrativi.
Fun Fact: non riprenderò mai più in mano Cave Story, ma lo mostrerò a primogenito e secondogenito che – una decina di anni dopo – lo termineranno entrambi.
A Nights In The Woods #21
A Nights In The Woods è stato il videogioco grazie al quale sono tornato a giocare ai videogiochi, nel 2017, dopo dieci anni di abbandono quasi totale. Fun Fact: il gioco mi era stato consigliato su Facebook in un thread in cui avevo chiesto consiglio su videogame con tematiche “mature”.
A Nights In The Woods mi ha fatto venire diversi brividini: è ancora adesso un gioco pieno di cose. Parla di provincia, di sogni che nascono per non essere realizzati, di disoccupazione, di rancori che restano covati per anni, di differenza di classe. E tutto questo lo fa con una protagonista che è una gattina antropomorfa, disegnata come un fumetto per bambini, il che fa stridere ancora di più quello che le succede.
Dopo la prima metà il gioco perde un po’ di compattezza virando verso una narrazione da romanzo di Stephen King, ma nel complesso l’universo regge fino alla fine. La cosa notevole di A Nights In The Wood sono le narrazioni, disseminate nel mondo, nei dialoghi, nei luoghi, dove non è detto che andremo per forza. Ci sono cose che non ho fatto in quel gioco e che non farò mai, ormai.
A Nights In The Woods è stato un vero giro di boa, dopo di lui ho scoperto altri giochi che mi permettevano di giocare senza dover sparare a tutto quello che incontravo, ma che raccontavano storie, micromondi, paure.
Drol #22
Drol sono io allo SMAU, che all’epoca era uno dei modi per venire in possesso di software fresco per Apple 2, vedere le nuove macchine, gli home computer che popolavano il mondo, modelli made in taiwan che sarebbero durati il tempo della fiera, cose che allora, negli anni ottanta, mostravano modelli che solo da qualche anno sono diventati di massa (tipo gli schermi touch screen, negli anni ottanta li ho provati, allo SMAU), Drol, dicevo, sono io che trovo questo stand che copia impunemente software per Apple 2 per i soldi del floppy, Locksmith 5.0 a tutto spiano, e mi compro questo videogioco a cui stanno giocando con questa grafica che – all’epoca – mi sembra bellissima, colonne doriche, robot, bambine che inseguono palloncini, cavalli marini che galoppano e sputano, demoni che saltano e imprecano, asce che roteano per l’aria, insomma, il solito nonsense dei videogiochi dell’epoca.
E poi, tornando da Milano, mi faccio tutto il viaggio fino a Genova con il floppy sotto al braccio sognando le partite che avrei fatto, con quei suoni 8-bit tutti spezzati, gli sprite belli grassi, la mamma legata nei sotterranei che aspetta che il suo robot la salvi buttandosi letteralmente tra le sue tette, insomma, cosa potevo desiderare di più?
Space Ace #23
Non ricordo assolutamente come venimmo a sapere che in piazza della Vittoria a Genova, in un bar che all’epoca giudicai come “fichetto”, ci fosse un cabinato con dentro Space Ace, uno dei due più famosi videogame su laserdisc (l’altro era Dragon’s Lair). Il bar era oggettivamente quanto di più lontano dal tipico bar con console e vedeva anche di cattivo occhio noi ragazzini che entravamo per giocare al videogame.
Space Ace, diciamocelo, era un mezzo pacco: non solo il gameplay era rigidissimo, ma costava anche il doppio rispetto a un normale videogame. Però era un pacco fatto con classe: era di fatto una sperimentazione, grossolana dal punto di vista della programmazione, ma estremamente interessante per quello che riguardava il comparto video e audio.
Da un certo punto di vista era uno dei primi videogame che cercasse di emozionare il giocatore usando strumenti e linguaggi che venivano dai media cinematografici.
Per dire, uno dei motivi per il quale andavo in quel dannato bar a spendere le mie 500 lire era il senso di avventura che trapelava dalle prime sequenze del gioco ma sopratutto per riascoltare la voce della ragazza rapita che urlava “get me out of here!” e che – sono abbastanza sicuro – arrivava al venerandi giocatore con un effetto surround stereo dalle casse poste sui due lati del cabinato. E venerandi si emozionava tutto.
Non l’ho mai nemmeno lontanamente finito: il gameplay era troppo meccanico, il gioco troppo costoso e il bar distava una ventina buona di chilometri da casa mia. Ma ecco, ancora oggi sono contento di esserci stato in quel momento, di avere provato il brivido di giocare a un gioco in laserdisc nel momento in cui era uscito, di averlo avuto nella testa a frullare, fermentare e far venire idee mentre lasciavo il bar e camminavo tra i relitti delle architetture fasciste genovesi.
Loom #24
Se dovessi scegliere i tre grandi videogiochi narrativi a cui ho giocato nei miei primi vent’anni di vita, escluse le avventure testuali che sono un mondo a sé, sceglierei senz’altro Ali Baba, Another World e Loom.
Loom era un lungo racconto fantastico, inframezzato da musiche di Tchaikovsky, un punta e clicca che poteva essere visto come il corrispettivo “serio” di Monkey Island, meno geniale e ironico, ma avvincente, compatto e capace di raccontare mondi.
Ci giocai con il mio Macintosh LC, il suo monitor a colori 12”, floppy disk dopo floppy disk. Ricordo che mi colpì questa unione tra magia, musica e l’idea del mondo come tessitura. L’emozione, ad un certo punto del gioco, quando il protagonista esce dal tessuto del mondo e si trova in un universo oltre quello della realtà sensibile: e oggi, mentre scrivo, mi chiedo se sia davvero successo o se sia una mia fantasia che nasce a trent’anni da quella lunga sessione di gioco.
Le pecore – ad un certo punto – diventano verdi, questo lo ricordo ancora distintamente.
(continua)




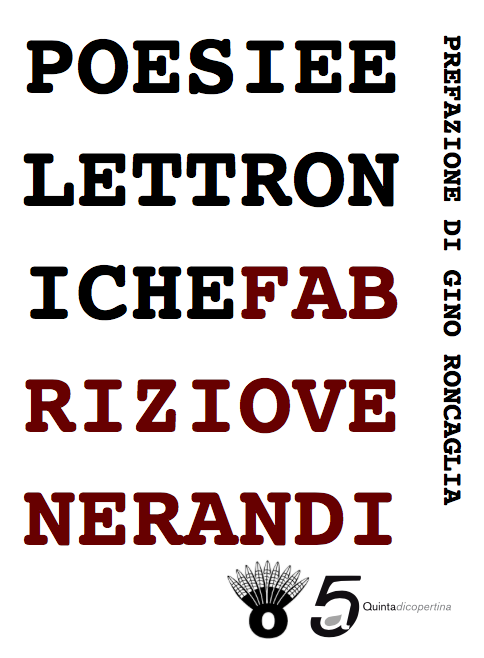


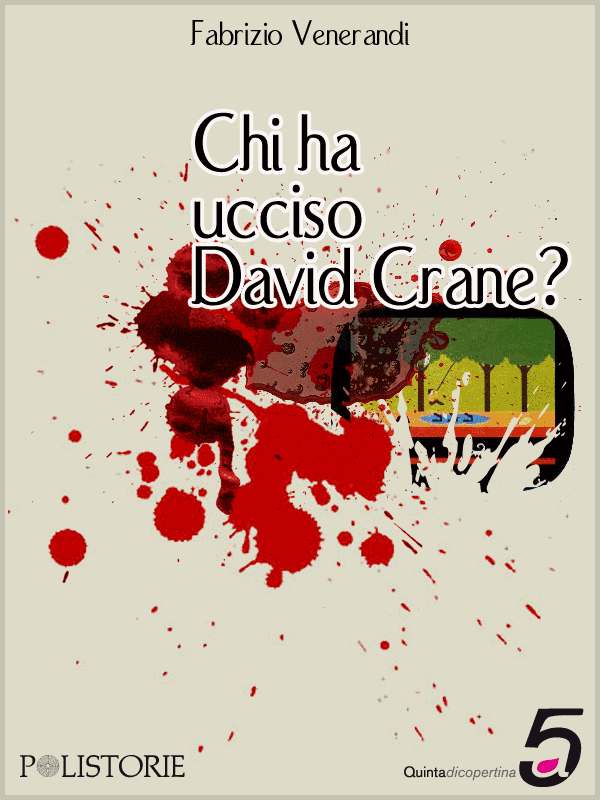



Finalmente due titoli che abbiamo in comune nella nostra storia videoludica: Escape From Rungistan e Loom.
Il primo grande, il secondo grandissimo.
Quante storie non intersecantisi di videogiocatori possono esistere?